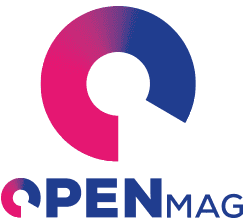85 anni fa nasceva a Roma l’autore di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”
Nel 2012, a trent’anni dalla sua prematura scomparsa, parte del cinema italiano e della critica hanno iniziato a interrogarsi sulla cappa di assoluto silenzio calata sulla figura e sull’opera di Elio Petri. Eppure, non sono numerosissimi i registi italiani vincitori di un Oscar, come lui con “Indagine”, miglior film straniero nel 1971. Eppure, la sua opera seconda, “I giorni contati”, ha battuto addirittura “Jules & Jim” di Truffaut al “Mar de la Plata Film Festival” del 1963. Eppure, “A ciascuno il suo” è l’unico film tratto da Sciascia che sia stato pienamente apprezzato dal grande scrittore siciliano. Eppure, “La decima vittima” ha portato su entrambe le sponde dell’oceano una ventata rivoluzionaria nel design, nell’iconografia, nel gusto scenografico (cui non è rimasto estraneo Stanley Kubrick). Eppure, le sue opere scorrettissime e poetiche, caustiche e struggenti, hanno offerto prove interpretative superbe. Sia tramite i suoi attori-simbolo come Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, Flavio Bucci, Salvo Randone e, naturalmente, il suo alter-ego sullo schermo Gian Maria Volontè; sia tramite fulminanti collaborazioni con Giancarlo Giannini, Franco Nero, Ursula Andress, su su fino a Ugo Tognazzi e Alberto Sordi.
Tra i più significativi e innovativi cineasti italiani degli anni ’60 e ’70, autore, molto spesso insieme al grande sceneggiatore Ugo Pirro e con le magistrali musiche di Ennio Morricone, di film sempre molto apprezzati dal pubblico e dalla critica straniera, grande esperto di teatro, pittura e letteratura, documentarista d’assalto, il regista romano è stato letteralmente sradicato dall’immaginario collettivo del nostro cinema. Molte delle sue opere sono state immerse per decenni in una semiclandestinità che solo oggi inizia forse ad attenuarsi. Volendo affrontare il tema con obiettività, la spiegazione non è impossibile da trovare: Petri è stato un intellettuale e un autore cinematografico assolutamente fuori dagli schemi, slegato da qualsiasi cordata, sgradito a qualsiasi potere, anche quello “amico”. Comunista doc, non ha mai fatto del suo cinema uno strumento di propaganda, a differenza di molti suoi, anche prestigiosissimi, colleghi. Un cinema senza sconti il suo, verso il potere democristiano, gli sfruttatori, gli abusi della polizia, i vizi del clero, lo strapotere perverso dei media, ma anche verso la sinistra, dipinta senza complimenti come intollerante, doppiopesista, inconcludente. In un’intervista a Dacia Maraini del 1973, dichiarerà di non aver mai perdonato al socialismo la sua connotazione “paternalista”. Negli anni d’oro del conformismo della gauche caviar, uno scandalo senza precedenti.
Gli inizi folgoranti, l’altra faccia del boom, l’incontro-scontro con Sordi
Nato a Roma il 29 gennaio 1929, padre operaio, madre cameriera, trascorre l’infanzia in Via dei Giubbonari, zona allora ultra-popolare. Attivista del Pci dall’immediato dopoguerra, a vent’anni è critico cinematografico de L’Unità. Diventa aiuto regista di uno dei maestri del neorealismo, Giuseppe De Santis. Ne apprende appieno la lezione, ma il suo stile guarda oltralpe. Innestando, sulla visione neorealista italiana, la lezione francese dell’esistenzialismo e lo stile cinematografico della “Nouvelle vague”.
Dopo l’apprendistato e vari cortometraggi, Petri inizia a mietere successi sul grande schermo, con “L’assassino” (di cui parleremo più avanti), protagonista Marcello Mastroianni, e “I giorni contati”, dedicato dal regista alla figura del padre, unica prova da protagonista del grande caratterista Salvo Randone.

Nel 1963, Petri sta lavorando alla sceneggiatura de “I mostri”, che dovrà essere interpretato da Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Il produttore Dino De Laurentiis però è piuttosto riluttante. Preferirebbe tornare a lavorare sull’adattamento del romanzo “Il maestro di Vigevano”, da lui stesso ceduto a Mario Cecchi Gori, che a sua volta l’ha affidato a un Dino Risi tutt’altro che convinto. Lo scambio è nell’ordine naturale delle cose: “I mostri” passa a Cecchi Gori, con Gassman e Tognazzi, e diventerà uno dei fiori all’occhiello della filmografia di Dino Risi. Elio Petri e Alberto Sordi partono insieme per la Lomellina per realizzare “Il maestro di Vigevano”. Il film, storia di un insegnante che rinuncia al suo status, economicamente modesto ma culturalmente importante, per cercare di soddisfare la sete di agiatezza della moglie, rimane uno dei simboli degli anni ’60 e una delle più acute ricognizioni dietro le quinte del boom. Sullo schermo si intuisce però anche lo scontro tra due personalità fortissime: un autore capace di guardare la realtà ai raggi X, che non intende lasciarsi mai distogliere dal suo progetto di cinema civile e psicologico allo stesso tempo, e un re della scena abituato a non essere mai soltanto interprete. Dalla presenza di Alberto Sordi, non può che nascere la pellicola meno personale di Petri.
La lezione di Kafka
In una filmografia di una dozzina di titoli, serpeggia continuamente il riferimento culturale a Franz Kafka. Con il gigante boemo della letteratura, il regista condivide l’ossessione per i temi dell’immensa solitudine dell’individuo schiacciato nella massa, dell’alienazione derivante dalla modernità, del diverso incapace di adattarsi all’ambiente circostante e destinato a soccombere. Uno sguardo “kafkiano” appunto, coniugato, soprattutto nella seconda parte della carriera, con un gusto deformante per il grottesco e per storie pessimistiche, straziate, nerissime.
Già l’esordio, “L’assassino” (1961), rimanda fortemente a “Il processo”, con un antiquario imbroglione (Mastroianni) che attraversa un’odissea giudiziaria senza conoscerne bene neppure il motivo. Proclama con forza la sua innocenza ma, gradualmente, apre gli occhi su ben altre colpe che gravano sulla sua esistenza. Con la parabola di questo moderno Josef K. coincide, a grandi linee, uno dei temi caratteristici di Petri, che gli procurerà le prime grane con la censura: quello della forza pubblica che agisce con metodi illeciti. Con notevole anticipo sui tempi, il regista illustra il disincanto e l’allontanamento dalla politica, in un’epoca in cui la fedeltà alle ideologie è ancora fortissima. “La politica m’ha deluso” risponde Mastroianni a un “compagno” che gli chiede se militi ancora nel “partito”. Una frase che appartiene in toto ai nostri tempi, ma incredibilmente controcorrente per i primi anni ’60.
“La decima vittima” (1965) è il film che fa passare al nostro cinema la voglia di occuparsi di fantascienza. Liberamente tratto

dal romanzo “La settima vittima” di Robert Sheckley. Anno 2000: il potere mondiale ritiene di aver trovato il modo di eliminare il crimine e la violenza dalla società: indire una gara chiamata “La grande caccia”. Ogni partecipante dovrà cimentarsi in dieci “cacce”. Alternativamente, per cinque volte dovrà riuscire a uccidere le vittime che gli vengono assegnate, per altre cinque dovrà riuscire a evitare di essere ucciso da un altro cacciatore. Marcello Mastroianni e Ursula Andress, veterani del gioco, si innamorano e cercano di sfuggire all’obbligo di eliminarsi a vicenda. Come un Karl Rossmann del futuro, protagonista di “America”, il “fuggiasco” Mastroianni affronta i nodi irrisolti di un sistema che, concepito per garantire la libertà, finisce per generare nuovi lacci che imbrigliano l’individuo. Cinematograficamente, il film risente dello scontro tra il produttore Carlo Ponti, che lo vorrebbe più umoristico e fantasy, e il regista che, neanche a dirlo, lo vorrebbe più politico. In ogni caso, “La decima vittima”, con le sue scenografie pop e geometriche, manda in visibilio i pubblicitari di tutto il mondo e influenza il design del decennio successivo. Le scenografie futuribili e il tema della violenza “controllata” dell’individuo lo rendono una più che probabile fonte di ispirazione per “Arancia Meccanica”.
“A ciascuno il suo” (1967), produzione indipendente tratta da Sciascia, fa riecheggiare il tema di fondo del romanzo “Il castello”: l’ostilità e l’ostruzionismo del potere che impediscono al singolo di vivere liberamente e addirittura di compiere il proprio dovere. In una provincia palermitana torrida e immobile, Gian Maria Volontè, un professore di liceo, naturalmente ex-comunista, inizia a sospettare che un duplice omicidio archiviato come passionale sia in realtà un regolamento di conti mafioso. Naturalmente è vero, e quello che lui reputa un mistero imperscrutabile è in realtà un’ovvietà tacitamente conosciuta da tutti. Indagando privatamente per sciogliere “l’enigma”, finirà dritto nelle mani del mandante del delitto, ignoto solo a lui. Rappresentata sempre come roccaforte del potere scudocrociato, la Sicilia di “A ciascuno il suo” è retta da un sistema di potere trasversale e inattaccabile in cui “l’opposizione” è perfettamente a proprio agio. Il deputato comunista interpretato da Leopoldo Trieste, superficiale e maneggione, a cui Volontè chiede invano di denunciare il delitto in Parlamento, in qualsiasi altro film sarebbe immancabilmente democristiano. Una sola cosa gli interessa: “Lo voti sempre il partito?” “Sì ma mi riesce sempre più difficile. E lo capisci il perché?”. Siamo un anno prima del 1968.
Il parallelismo con Kafka si chiude con la morte del protagonista. Deviando dal romanzo, Petri uccide il proprio protagonista nello stesso modo in cui, nella versione cinematografica de “Il processo”, Orson Welles decide di far morire il “condannato” Josef K: con una carica di dinamite. Il professor Paolo Laurana salta in aria in una solfatara, in una deflagrazione che scuote la quiete perversa del film. Non si può nemmeno dire che porti con sé i suoi segreti, perché segreti non ne esistono. I notabili del paese si strizzano reciprocamente l’occhio e tracciano il suo epitaffio: “Era un cretino”. Così Petri allarga ulteriormente il fossato tra se stesso e la cultura ufficiale italiana, sbeffeggiando l’incapacità degli intellettuali di leggere la realtà, condannando ogni propria iniziativa all’inefficacia.
E’ un Gregor Samsa in abiti moderni il Flavio Bucci di “La proprietà non è più un furto” (1973). Un pavido impiegato di banca che

subisce una “Metamorfosi” che lo rende inabile al suo lavoro e a vivere nella società in generale: diventa allergico al denaro. Si trasforma allora in un “marxista mandrakista”. Ruba ai ricchi tutto ciò che occorre alla sua sussistenza. Mai denaro, solo cose. Crede di trovare la propria vendetta sul mondo consumista e sull’avidità umana perseguitando un sordido e disonesto macellaio pieno di soldi, Ugo Tognazzi, derubandolo continuamente di ogni cosa, compresa la sua cassiera-amante-oggetto Daria Nicolodi. Menzione speciale per il sottofinale al cimitero del Verano, con il ladro Paco l’argentino (Gigi Proietti) che pronuncia l’orazione funebre per un collega caduto “sul lavoro”, tessendo “l’elogio del ladro”.

Senza contare che Elio Petri non ha potuto completare l’adattamento cinematografico del racconto “Nella colonia penale”, si conclude con una citazione di Kafka il film-monumento del cineasta, premiato dal massimo riconoscimento cinematografico mondiale: “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, opera incentrata sul tema dell’intangibilità del potere. E’ il secondo atto, e probabilmente il punto più alto del suo sodalizio artistico con Gian Maria Volontè.
Gian Maria Volontè, l’Oscar, l’abisso di “Todo modo”
Un commissario di polizia, della squadra politica, uccide la propria amante (Florinda Bolkan) e, come sfida, dissemina tracce e indizi per essere scoperto. Il film esce in una fase cruciale degli anni di piombo e appare da subito a rischio sequestro. Per accontentare le interminabili file di spettatori fuori dai cinema, vengono fissati spettacoli anche dopo la mezzanotte.
Nel ’72 l’ormai collaudata coppia Petri-Volontè incassa critiche roventi dalla Fiom e picchetti fuori dai cinema con “La classe operaia va in paradiso”, storia di un operaio krumiro che, dopo aver perso un dito in un incidente in fabbrica, sia avvicina alla sinistra extraparlamentare. Il film è accusato di essere sostanzialmente anti-sindacale. Ma non è ancora nulla.
E’ portando sullo schermo un altro libro di Leonardo Sciascia che Elio Petri conquista di diritto un posto tra gli artisti “maledetti” di ogni tempo. Nel 1976, esce “Todo modo”. Si tratta di un atto d’accusa ferocissimo contro il sistema di potere democristiano. Trama: mentre in Italia infuria un’epidemia, la classe dirigente del partito di governo si riunisce in un eremo per svolgere gli annuali esercizi spirituali sotto la guida di un sacerdote molto poco raccomandabile. Uno dopo l’altro, si verificano feroci delitti. Oltre a incontrare la prevedibile ostilità della stampa centrista, il film registra anche il gelo dei comunisti, poiché arriva in pieno Compromesso storico, in una fase di distensione tra Dc e Pci. Nel film inoltre alcuni personaggi politici sono riconoscibilissimi. Ciccio Ingrassia, ascetico ed esasperato, sembra Zaccagnini; un Michel Piccoli silente e minaccioso ricorda Andreotti (tutti lo chiamano soltanto Lui…). Ma soprattutto, è il personaggio di Gian Maria Volontè, il Presidente, ad essere ricalcato sulla figura di Aldo Moro (i primi due giorni di girato saranno buttati, perché la somiglianza è eccessiva). Il garante del compromesso storico è raffigurato insieme alla moglie (Mariangela Melato) come un politico assetato di potere e divorato dalla follia. Decisamente non il massimo della correttezza politica. Dopo l’uccisione di Moro, “Todo modo”, che già alla sua uscita ha suscitato forti imbarazzi ed è stato ritirato dalle sale dopo meno di un mese, diventa letteralmente un film fantasma, rimanendo invisibile per decenni.
“Ho fatto film sgradevoli”

Elio Petri lascia diversi progetti incompiuti, ma soprattutto un grande vuoto nella libertà intellettuale e nella forza spettacolare del nostro cinema: “Nell’ultimo periodo della mia vita, io ho fatto film sgradevoli. Sì, film sgradevoli in una società che ormai chiede la gradevolezza a tutto, persino all’impegno: se l’impegno è gradevole, e quindi non dà fastidio a nessuno, lo si accetta. Altrimenti no. I miei film, al contrario, oltrepassano addirittura il segno della sgradevolezza”.