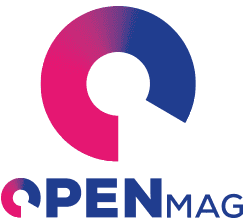Apro l’ultimo cassetto, lucido la mia rivoltella nove millimetri, conto i proiettili, carico i proiettili, scarico i proiettili. Punto la pistola allo specchio e chiudo gli occhi. L’ operazione Nemesis ha inizio.
Mi arriccio i capelli e mi avvicino alla porta di questa locanda dimenticata. Ho sempre pensato che questa sarebbe una bella scena per l’introduzione o la conclusione di un libro: il protagonista dietro una vetrina opaca che guarda fuori la pioggia scivolare e sparire tiepida.
Mi arriccio i capelli, cammino e mi incazzo.
Nel buio tutto ha la stessa non forma. In giro, pochi passi e poche scarpe danno il ritmo a un rubinetto che perde. Sono sul vialone di casa mia, gli alberi non fioriti scivolano giù delle foglie che l’ultima pioggia ha combattuto e vinto. Passeggio e incontro un mio vicino. Lo guardo con occhi diversi. Cammina con la schiena dritta come un fiume che corre placido, con la testa che sembra guardare oltre, alto come è.
Io ho sempre camminato un po’ ricurvo e spesso, camminando, mi guardo le scarpe bucate remare nelle pozzanghere.
Io non so camminare come lui.
Era il 28 luglio 1915.
Faceva un caldo torrido e giocavo con il mio amico Vahram. Avevamo costruito un enorme circuito per le biglie a inizio estate e ogni giorno modificavamo le innumerevoli gobbe. Ricordo che quella settimana un temporale di quelli giusti aveva eliminato la seconda e la terza curva. In compenso, il nuovo fango permetteva nuove idee.
Io disegnavo il progetto, Vahram lo rendeva reale.
Io ero la nuvola, lui la pioggia.
Era il 28 luglio e l’esercito turco si presentò nel mio villaggio di Chorum.
I miei genitori e quelli di Vahram erano benestanti e riuscirono a chiedere due carri e un prestito economico agli amici turchi.
Io e Vahram iniziammo il viaggio nello stesso carro con il mio fratellino e la mia sorellina. A guidarlo il mio babbo. Non capivo cosa stesse accadendo, ma ero spensierato e tranquillo. Avevo le biglie, avevo i miei fratellini, avevo Vahram e avevo i miei genitori.
Nulla di brutto poteva accedere.
Una lunga fila di persone in marcia verso qualcosa, da qualche parte; come una biglia in un rettilineo infinito. Un circuito immaginario, mal disegnato, in cui non si passava mai dal via e in cui il traguardo era una chimera.
Torno a casa con le calze inzuppate, lancio le scarpe dietro la cassapanca all’ingresso. In questo freddo appartamento non vorrei rimanerci troppo. Devo riuscire a trovare il coraggio il prima possibile e poi magari fuggire da questa piovosa città, così diversa da chi sono io.
Mi siedo alla scrivania, accendo la lampada. Fioca, ballerina, tremante.
Prendo la matita e disegno. Poi apro il secondo cassetto sulla sinistra, prendo il pastello rosso e coloro il vestito di mia mamma. Quello marrone per i pantaloni del mio babbo. Quello giallo per i capelli arruffati del mio fratellino. Un pastello alla volta, ho bisogno di ordine. Riprendo la matita e ricalco le figure. Firmo con una esse in basso a sinistra.
Sono tutti uguali i miei disegni, specchio dei miei sogni. O incubi.
Mi alzo e mi avvicino alla finestra.
Ricomincia a piovere dai miei occhi, stufi di legare le lacrime come bimbi cresciuti che non accettano più di camminare mano nella mano con la propria mamma.
Così, sciogliendo il nodo della sua mano, balzai giù dal carro. Era mattino presto e la marcia era appena ricominciata quando delle urla agghiaccianti imposero lo stop. Mio padre non riuscì a coprirmi gli occhi e vidi tutto.
Vidi soldati turchi prendere dei bambini dai piedi. Vidi soldati turchi sbattere la testa di questi bambini sulle rocce. Vidi rivoli di sangue dalle tempie. Vidi corpi giacere teatralmente sul lembo dell’Eufrate. Vidi e rimasi impietrito.
Lasciai cadere il mio sacchetto di biglie a terra, sentii il tonfo sordo su un ciuffo d’erba: joff…
Mi girai, volevo scappare, ma Vahram mi anticipò. Gli tagliarono la gola a qualche metro da me. La guardia non perdonò neppure sua madre per evidente negligenza.
Non tornai a prendere mai più le mie biglie.
Mi sveglio vestito come ieri sul divano color biglia più veloce. Verde leggero. Mancano tre giorni. Coloro il cielo di Berlino sul disegno di ieri sera. L’inverno sta finendo, ma il grigio non finisce mai.
Berlino è una città spenta e immobile. Non è in grado di creare alcuna emozione in me.
Prendo la matita e disegno. Apro gli stessi cassetti e prendo gli stessi pastelli per rifare lo stesso disegno. Sullo sfondo, l’Eufrate colorato di porpora, io girato di spalle e dietro di me la mia famiglia e quella di Vahram. Dietro di me solo fantasmi. Tutti girati di spalle, tutti impietriti a guardare l’orribile.
I miei disegni rappresentano sempre questa scena. Ne ho fatti una quarantina, come se quello fosse l’unico ricordo della mia infanzia. Non lo è forse, ma che importanza possono avere gli altri ricordi?
Ripeto come un automa, metodicamente, sempre le stesse figure. Ne cambio i colori a volte, in base alla quantità di odio presente nel mio sangue.
Apro l’ultimo cassetto, lucido la mia rivoltella nove millimetri, conto i proiettili, carico i proiettili, scarico i proiettili. Punto la pistola allo specchio e chiudo gli occhi.
Con una mano mi arriccio i capelli, con l’altra pettino i miei pensieri…
Mia mamma cadde due giorni prima di raggiungere Katma. Era il 4 settembre. Sfinita, senza forze, dimagrita, rugosa, sporca. Cadde di faccia e raggiunse la mia sorellina di 4 anni.
Le mosche volavano sui miei capelli duri come spighe di grano. Adoravo mettere la mano tra i miei capelli, ma in quei giorni no. Non c’era spazio per nessun tipo di piacere. Passarono un paio di settimane e il mio fratellino ritornò ad abbracciare il caldo corpo di mia madre.
Rimasi solo con mio padre e il padre di Vahram.
A quel punto i cinquecento pezzi d’oro furono sufficienti per porre fine alla nostra agonia. Non prima di aver vissuto una settimana nel campo per deportati di Aleppo.
Non assaporai l’ebbrezza del pane per due mesi, non sciacquai il mio corpo per due mesi, fui attorniato da insetti per giorni e notti intere, camminai a piedi nudi tra i crinali delle montagne, soffrendo il freddo notturno con vestiti trasparenti, ebbi conati di vomito, conobbi la fame, aiutai madri a partorire sul ciglio della strada, vidi neonati presi a calci, sentii donne urlare tutte le notti, sentii soldati turchi sghignazzare tutte le notti, vidi il mio corpo mutare forma e divenire sempre più snello, fui costretto a spostare cadaveri dimenticati in mezzo alla strada polverosa, toccai polpacci larghi come polsi.
Tutto questo non era paragonabile al campo di Aleppo.
Non piove, esco dalla locanda e aspetto il mio vicino seduto sulla panchina chiacchierando con una ragazza di cui non mi interessa assolutamente nulla. La mia unica preoccupazione è che lui non mi noti. Eccolo che arriva, con una camminata troppo calma, lo sguardo troppo fiero e gli occhi che guardano oltre, fuori da lui, fuori dalla sua realtà, come se stessero cercando conforto in qualcosa che non troveranno mai. Per non incontrare quello sguardo ladro di speranze, bacio quella ragazza avara di emozioni.
Sarebbe il primo grande atto dell’ Operazione Nemesis. Non il bacio.
Torno leziosamente a casa percorrendo la scorciatoia più lunga, affinché scorciatoia non sia più. Guardo la punta delle mie scarpe, alzo il braccio sinistro e appoggio tra il mio indice e il mio medio un ciuffo riccio. Dopodiché lo attorciglio come fosse una vite su cui appendere lo specchio dei miei occhi. Un mio quadro, il mio quadro.
La notte arriva da dietro e non porta con sé alcuna voglia di chiudere gli occhi. Sarà la tensione della penultima notte.
Apro l’ultimo cassetto, la guardo. La rivoltella brilla di luce propria e, brillando, lascia una scia di polveri di ricordi svaniti nelle terre dell’Anatolia. La scia delle biglie su quel circuito faticosamente costruito.
Ho superato tutte le gobbe del circuito della mia vita, anche la più alta, tra la quinta e la sesta curva. Mi manca quella dopo l’ottava. Poi inizia il rettilineo della mia vendetta.
Il disegno di stanotte sarà in tonalità di grigi. Solo un colore accetto: il rosso dell’Eufrate.
Il campo di Aleppo superò qualsiasi orizzonte. Per perdersi oltre, nel nero di una rivoltella lucente. Se penso ad Aleppo, giustifico ogni mia azione.
Tutto intorno al campo costruzioni dell’inaccettabile. Tre oblique palizzate di legno legate in alto da una corda. Un’altra corda calata dal punto centrale di questo incrocio da cui pendeva ermetico un cappio. Tutte le sere, processioni silenziose di volti sbiaditi si avvicinavano a queste costruzioni.
Passai una sola notte all’interno di una piccola e modesta fattoria contenente più di trecento persone. C’era chi piangeva, chi era praticamente nudo, chi tossiva in continuazione, chi tremava, chi aveva dei bubboni sulla pelle, chi mangiava carne umana, chi beveva la propria urina, chi urlava in preda all’isteria, chi tentava la fuga, chi il suicidio.
Non fui in grado di chiudere occhio quella notte.
Madido di sudore, mi risveglio con la stessa maglietta color vestito di mia madre. L’incubo di quelle scene mi perseguita, non riesco a riposare la mente. Da anni.
Io sono salvo e sono qui perché gli amici turchi di mio padre ci prestarono cinquecento pezzi d’oro.
Lasciammo Aleppo in treno e tornammo in Turchia, la attraversammo interamente fino a Istanbul. Fu un viaggio spaventoso: ad ogni stazione avevamo paura ci riconoscessero e ci riportassero ad Aleppo. Non fummo tranquilli fino al raggiungimento dell’ambasciata francese dove mio padre aveva conoscenze fortunate. Ci salvammo così.
Qualche anno dopo, a Parigi, nel quartiere di Montmartre, mi si avvicinò Armen Garo. Il vino rosso mi portò ad accettare la sua Operazione Nemesis.
Maledico quel vino rosso.
Ma maledico di più altre cose ed altre persone. Ho avuto la fortuna di salvarmi e adesso devo saldare questo debito.
Passeggio nervosamente, guardo fuori dalla finestra e giochicchio con le dita appoggiando sul marmo ruvido del davanzale prima il mignolo, poi l’anulare, a seguire le altre dita. Continuo a ripetere questo gesto, sono teso.
Mi immagino la scena e mi chiedo se sia meglio sparargli in faccia guardandolo negli occhi o da dietro, colpendolo alla nuca.
E se si girasse in quel momento?
E se scappasse?
E se si fosse accorto che lo pedino da settimane?
Mi ribolle la mente, mi sciacquo il viso e inizio a bere della vodka liscia. Decido di disegnare, ma non riesco ad ordinare i pastelli e non mi piace disegnare disordinato. Il foglio bianco si anima con qualcosa: disegno il suo viso, poi il suo corpo alto.
Lui a destra, io a sinistra.
Sul secondo foglio disegno sia me che lui di spalle.
Sul terzo la rivoltella che punta la sua nuca.
Sul quarto la rivoltella che punta la sua faccia.
Mi addormento su quest’ultimo ritratto.
Mi risveglio con i suoi occhi cerulei che mi fissano. Sembrano prendere vita. Guardo fuori e si è fatto buio: ho dormito più del previsto. Non guardo l’ora, mi oriento con la luce del non sole e so che è tardi.
Il mio stomaco brontola, ma sono sordo a questi lamenti oggi. L’ansia mi pervade e mi avvolge. Conto e riconto i proiettili, carico e ricarico la rivoltella. Non ho fatto altro che disegnare e caricare proiettili nell’ultimo mese. Anzi, ho anche immaginato. Ora è il momento della non immaginazione, ma della realtà.
Mi fermo a bere l’ultimo bicchiere di vodka.
Mi arriccio i capelli e mi avvicino alla porta di questa locanda dimenticata. Ho sempre pensato che questa sarebbe una bella scena per l’introduzione o la conclusione di un libro: il protagonista dietro una vetrina opaca che guarda fuori la pioggia scivolare e sparire tiepida.
Mi arriccio i capelli, cammino e mi incazzo.
Nel buio tutto ha la stessa non forma. In giro, pochi passi e poche scarpe danno il ritmo a un rubinetto che perde. Sono sul vialone di casa mia, gli alberi non fioriti scivolano giù delle foglie che l’ultima pioggia ha combattuto e vinto. Passeggio e incontro il mio vicino. Lo guardo con occhi diversi. Cammina con la schiena dritta come un fiume che corre placido, con la testa che sembra guardare oltre, alto come è.
Io ho sempre camminato un po’ ricurvo e spesso, camminando, mi guardo le scarpe bucate remare nelle pozzanghere.
Io non so camminare come lui.
Quella camminata troppo calma mi urta. Quella schiena troppo dritta mi innervosisce. Quella schiena dritta e placida come un lembo d’Eufrate mi imbastardisce. Non capisco più niente.
Carico la rivoltella, la punto al non specchio davanti a me, mi avvicino con passo celere e ritmato.
Lui fa in tempo solo a girarsi di profilo.
L’ Operazione Nemesis ha inizio.
E’ il 15 marzo 1921, nella Hardenbergstrasse del quartiere Charlottenburg di Berlino, Soghomon Tehlirian si avvicina a Talat Pascià, l’ex potente ministro dell’interno dell’Impero Ottomano, la vera anima che organizzò e coordinò il genocidio degli armeni, e gli spara un colpo alla nuca con una rivoltella automatica da nove millimetri.
Durante il processo, Soghomon dichiara di aver agito da solo, ma su mandato della madre, del fratello, della sorella, della famiglia e dell’intero popolo armeno.
Tuttora non è accertato se questo fu il primo atto dell’ Operazione Nemesis o il semplice attentato di un isolato vendicatore di nome Soghomon. Tuttavia, l’operazione Nemesis, ideata dal partito armeno Dashnak, consistette nel giustiziare i responsabili del genocidio armeno sfuggiti alla condanna perché scappati all’estero.
Soghomon Tehlirian venne dichiarato ‘non colpevole’. Il suo colpo alla nuca venne catalogato come un atto di legittima difesa.