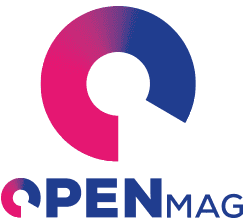Mi chiamo Zbigniew Zajdel e da circa settanta anni odio il Brigadefuhrer delle SS Odilo Globocnik.
…Salii su una camionetta color verde militare mentre la pioggia mi inzuppava le calze e quel soldato ci faceva i complimenti per i nostri capelli biondi e i nostri occhi azzurri…
Di corsa arrivò un altro soldato, urlò qualcosa di incomprensibile. Tutti si girarono verso di lui ed iniziarono a correre verso il centro di Sochy. Odilo fece capolino per qualche secondo fuori dalla mia fattoria e parlò con il soldato corridore. Rientrò in casa e, come se nulla fosse, mi lasciò orfano; dopodiché uscì ridacchiando disgustosamente e corse anche lui. O almeno credo mi lasciasse orfano: sparò una decina di colpi di mitragliatrice e, successivamente, non trovai il nome di mia madre in nessun elenco dei morti dei tre campi di concentramento che circondavano la mia regione: Belzec, Sobibor e Majdanek.
La mezzora successiva fu un continuo sentire di urla frammiste a proiettili. Probabilmente, tutti gli abitanti si erano rinchiusi nell’ampio sottotetto del municipio e lì furono trucidati come formiche.
In quella camionetta salirono altri miei piccoli amici e compagni di scuola, circa una dozzina, non di più, comprese due ragazze ventenni pressoché svestite.
Appresi dai libri di storia che quella notte a Sochy furono uccisi centoottantatre abitanti su centonovantasei. Appresi dopo che quelle poche persone che fecero con me quel terribile viaggio erano le uniche superstiti del massacro avvenuto nel mio villaggio.
Il 6,63% degli abitanti del villaggio. Grazie a te, Odilo.
Tra quelle tredici persone io e Teofil.
Ci portarono a Lodz in un centro in cui ci rilasciarono delle carte d’identità, le stesse in cui c’era scritto WE. Su queste non compariva il mio nome. Quando chiesi perché, una grossa bionda con le guance rosse mi rispose che era stato tradotto in tedesco.
Gottlieb Seidl. Io non capivo.
Sono passati anni e ancora non capisco.
Passammo anche qualche notte nel campo di Majdanek continuando a fare esami fisici, ma non solo. Testavano, attraverso ‘indagini psicosociali’, il nostro potenziale livello di germanizzazione. Io continuavo a non capire.
Mio fratello andò via due o tre giorni prima di me. Non ricordo precisamente il giorno, ma era sicuramente ancora estate perché un temporale mi bagnò le calze anche la seconda volta che salii su una camionetta verde.
Mi trovai figlio di Anke e Jorg Heinrich. Cambiai ancora nome.
Gottlieb Heinrich.
Loro erano semplicemente deliziosi. Più anziani dei miei genitori, ma più giovani dei miei nonni. Abitavano a Dresda, città splendida ed erano proprietari di una piccola panetteria.
Loro non erano nazionalsocialisti e a casa capitavano altre persone che non lo fossero. Tutti parlavano dei difetti del Fuhrer ed io mi chiedevo chi fosse sto ‘Furie’ e cosa volesse dai polacchi. Scoprii più tardi, dai racconti di altri polacchi della mia età che fui fortunato a capitare in una famiglia del genere.
Ero piccolo e non capivo niente delle dinamiche del conflitto in atto. Lavorai nella panetteria Heinrich per un anno e scoprii il nome di tutti i panini. Poi, improvvisamente il 7 ottobre del 1944 gli americani bombardarono Dresda. Io non capivo cosa volessero questi americani. Tre mesi dopo, il 16 gennaio 1945, buttarono altre bombe e colpirono la ‘nostra’ casa mentre eravamo al lavoro.
Perciò ci spostammo nella casa di campagna. Dresda fece le fine che fece a causa degli incivili bombardamenti del 13, 14 e 15 febbraio. Noi ci salvammo fortunatamente.
In campagna la vita era simile a quella della fattoria e il mio umore migliorò, per quanto fosse possibile. Io immaginavo i ricci della mia mamma e gli occhiali del babbo, le mani morbide della nonna e la vodka del nonno. Ma soprattutto pensai al mio fratellino. Mi mancava terribilmente Teofil.
Quella primavera la guerra finì e quel ‘furiè lì’ morì. Per l’onore della Germania, il 1° maggio. Mi ricordo che stavamo ascoltando Radio Amburgo e la Settima Sinfonia di Bruckner venne interrotta da un annuncio del genere: ‘Apprendiamo dal quartier generale del Fuhrer che il nostro Fuhrer Adolf Hitler, combattendo fino all’ultimo respiro contro il bolscevismo, è caduto per la Germania”.
Io rimasi interdetto perché non compresi il motivo di interrompere una canzone per quello lì che cade. Poi vidi Anke e Jorg abbracciarsi e singhiozzare tra le lacrime, perciò immaginai che il tedesco imparato fino a quel momento non mi permise di tradurre in maniera corretta il senso della frase.
Quello lì era finalmente morto.
Scoprii più tardi che non morì combattendo fino all’ultimo respiro, ma si suicidò, come il peggior vile.
Alla faccia della razza superiore nordica.
Conobbi quel maggio altri due giovani polacchi, i quali avevano come me quattordici anni e si ricordavano nitidamente della loro infanzia. Si ricordavano almeno il loro nome, il loro cognome e il villaggio da cui provenivano. Qui, in questo punto, sta la differenza sostanziale.
Noi ricordavamo perché fummo rapiti a undici, dodici e tredici anni.
Fortunati perché un paio di anni in più ci avrebbero condotti diretti verso il lavoro coatto nei campi di concentramento. Sfortunati perché ricordavamo.
Partimmo a piedi in quella primavera magica. Fu un viaggio indescrivibile. Attraversammo prima la Slesia, poi la Galizia. A piedi. Si parlava di Polonia libera, di democrazia, di liberalismo e di quell’utopia di cui comunque non mi fidai neppure in quel momento.
Era qualcosa di indescrivibile. Era la quiete dopo la tempesta. Era il desiderio di costruire una nuova Polonia.
Tornai a Sochy, nella mia adorata Zamojszczyzna, verso la fine di giugno. Qualche colono tedesco rimase lì e fu ben accolto dai polacchi di ritorno. D’altronde loro erano poveri contadini come noi, spostati da una regione all’altra come fossero i minuscoli carri armati di un Risiko.
Dei tredici che partirono quell’infausta notte, solo in quattro fecero ritorno, due del 1930 e due del 1931, i quattro più grandi praticamente.
Quattro su centonovantasei. Senza percentuale questa volta.
Mio fratello non tornò. A chi rivolgersi? Il primo anno non capii nemmeno a chi dovessi chiedere. E poi cosa chiedere?
In un ufficio di Lublino, il giorno del mio sedicesimo compleanno iniziai a capire.
Era il 12 novembre del 1946 e nevicava come mai avevo visto nevicare in novembre. Il treno sbuffò lentamente fino alle macerie di Lublino. Scesi e mi incamminai verso il municipio.
Impiegai un po’ di tempo a trovare l’ufficio adatto e fui costretto ad attraversare un cortile interno del municipio. Completamente allagato. Mi inzuppai le calze, crudo presagio.
L’ufficiale militare mi spiegò che non era possibile trovare mio fratello.
Verso la fine della guerra, quando oramai era chiaro che il baratro stava inghiottendo gli ultimi sogni nazisti, i capi delle SS estrassero dal cilindro l’ultimo colpo: bruciarono il centro di Lodz, quello in cui ci diedero le carte d’identità buone per incartarci le uova.
Negli schedari di quel centro, i certificati che documentavano il primo cambio nome. Senza il primo cambio nome, come comprendere il secondo? Cercai tra i nomi e i cognomi simili. Inutilmente.
Mentre i centri di accoglienza tedeschi erano pubblici, quello di Lodz era inaccessibile ai funzionari civili del Reich. All’interno solo militari. Insomma, era tutto già previsto nella loro diabolica mente. Le persone a cui avevano cambiato nome sarebbero rimaste tedesche a vita.
Una sola strada era percorribile: il ricordo, la memoria personale. Chi la possedeva, tornò in Polonia. Chi non la possedeva, non la possiede tuttora e non sa nemmeno di cosa sto parlando.
Dei bambini polacchi della mia Zamojszczyzna, solo uno su cinque riprese la via Slesia-Galizia. Gli altri vivono beatamente in Germania, convinti di essere tedeschi. Convinti di un’altra vita, di un’altra mamma, di un altro papà, di un’altra nonna, di un altro nonno, di un altro villaggio, di un’altra palla, di un’altra stalla, di un altro campo, di un’altra biglia, di un altro cicchetto di vodka alle erbe, di un’altra coperta, di un’altra posata, di un altro bicchiere e di un altro mazzo di carte.
Convinti di altro.
La brezza mi accarezza la barba e la salsedine mi fa arricciare il naso come un gatto affamato attento agli odori.
Passeggio pensoso nel ‘Bosco della Strega’ di Tisvildeleje in Danimarca. Mano nella mano con Rosa, una berlinese il cui nome tradisce l’attivismo politico dei suoi genitori tedeschi. I nostri genitori hanno fatto la fine di Dresda e del centro di Lodz. Ma riusciamo a superare questi dolori.
Entro in una pozzanghera e mi sento le calze inzuppate. E il pensiero scivola a lui.
Mio fratello potrebbe essere ancora lì, da qualche parte. E’ inaccettabile vivere con questo rimorso.
Chissà che ricordi ha lui di quella sera, se li ha. Se ricorda come lo zittivo, se ricorda come gli asciugavo le lacrime, se ricorda la sua vera vita, la sua vera mamma, il suo vero papà, la sua vera nonna, il suo vero nonno, il suo vero villaggio, la sua palla, la stalla, il campo, la sua biglia, il cicchetto dei giocatori di carte, la coperta di quella notte, la sua posata ricurva da bimbo, il suo piccolo bicchiere e il mazzo di carte.
Per tutto ciò, io odio Odilo.
Perché io ricordo tutto, mentre Teofil non ricorda niente.