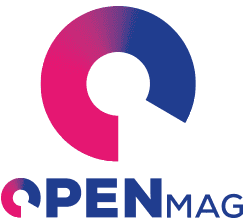Nella Storia, il cinema è stato un formidabile veicolo per la libertà d’espressione ma anche il suo contrario. Cosa succede quando ispirazione, talento narrativo, qualità tecnica della Settima Arte vengono convogliate al servizio dei totalitarismi.
Racconta Patrick Robertson nel suo I record del cinema (Gremese) che, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, Il grande dittatore di Charlie Chaplin totalizzerà un unico spettatore sul suolo tedesco: Adolf Hitler. Dopo aver proibito il film in tutta la Germania infatti, il Führer ne farà arrivare una copia a Berlino attraverso il Portogallo neutrale e lo vedrà, in assoluta solitudine, per due volte.
La prima nazione al mondo ad abolire la censura è la Russia rivoluzionaria governata da Aleksandr Kerenskij, nel marzo 1917. Reintrodotta di fatto dai bolscevichi, viene ripristinata ufficialmente nel 1922 fino a diventare, in epoca staliniana, la più severa del mondo. Incappando talvolta in qualche svista. Sempre secondo il libro di Robertson, nel 1940 la censura sovietica approva la distribuzione di Furore di John Ford, perché descrive accuratamente la miseria in cui sprofonda il popolo americano dopo la crisi del ’29. Dopo qualche tempo, l’autorizzazione viene ritirata: il pubblico dell’URSS è fortemente impressionato dal fatto che la poverissima famiglia di protagonisti possieda comunque un’automobile.
Il rapporto tra celluloide e totalitarismo però non è affatto solo di proibizioni e divieti. Le dittature sfrutteranno al massimo il potenziale mediatico e propagandistico del cinema per raggiungere i propri obiettivi. Il risultato è che pezzi importanti, a volte imprescindibili, della storia del grande schermo avranno come committente la dittatura.
Nel 1930, la produzione cinematografica tedesca ammonta a 180 lungometraggi all’anno, rispetto ai 485 di dieci anni prima. I trionfi dell’Espressionismo sembrano lontani, molti registi sono partiti per l’America. Nella crisi in cui versa la fragile democrazia di Weimar, iniziano ad affacciarsi sullo schermo pellicole che propugnano un “uomo nuovo” tedesco, valoroso e, naturalmente, imbattibile. Come in Tempeste sul Monte Bianco (1930), la cui protagonista femminile, Leni Riefenstahl, con l’avvento del nazismo tre anni dopo, diventerà la regista ufficiale del regime.
Amica personale di Hitler, mai iscritta al partito, Riefenstahl immortalerà immagini, parate, voci, rituali del regime in documentari come La vittoria della fede, Il trionfo della volontà, Il giorno della libertà: il nostro esercito, Olympia. Opere delle quali, al di là del giudizio storico-politico-morale sul contenuto, sarebbe difficile negare l’alto livello tecnico. Dopo la guerra, Leni Riefenstahl tenterà di minimizzare la sua adesione al nazismo e proseguirà la sua attività di documentarista e fotografa. Morirà a 101 anni nel 2003.
Tra i preferiti di Goebbels c’è il film sovietico La corazzata Potëmkin (1925). Il n. 2 del Reich lo considera, a ragione, un capolavoro di capacità propagandistica, oltre che di tecnica, firmato da un astro nascente del cinema dell’URSS: Sergej M. Ėjzenštejn. Rispetto al cinema del regime tedesco, quello sovietico ha esigenze parzialmente diverse. Se il primo mira a fare tabula rasa della cultura precedente nella testa del proprio popolo ed a convertirlo a parole d’ordine tragicamente nuove, il secondo deve educare al comunismo decine e decine di milioni di contadini, operai, minatori, allevatori, molto spesso analfabeti e sprovvisti di un bagaglio culturale preesistente.
Dunque, nei primi anni ’20, il cinema dell’URSS di Lenin si attesta su tre tendenze fondamentali: adattamenti di classici letterari per diffondere la cultura russa; umorismo e spettacoli popolari; cinegiornali. Emerge da queste premesse la generazione di Ėjzenštejn. Nato a Riga, in Lettonia, nel 1898, oltre a quello sulla celebre corazzata, il suo nome è legato a film come Sciopero!, Ottobre, Aleksandr Nevskij, Ivan il Terribile, l’incompiuto Que Viva Mexico! Pellicole che ne fanno forse il massimo teorico del montaggio cinematografico e che hanno come base ideale la celebrazione della Rivoluzione.
Una visione destinata fatalmente a scontrarsi con il nazionalismo e il “culto del capo” a cui è chiamato il cinema russo sotto Stalin. Negli anni ’30, la nomenklatura guarda all’autore lettone con crescente diffidenza, complice anche il lungo viaggio compiuto in USA, sotto contratto con la Paramount, e in Messico per raccogliere materiale sul film sulla Rivoluzione che non terminerà mai. La Pravda punta il dito apertamente contro i “maniaci del montaggio”. L’impeto rivoluzionario degli anni ’20 è solo un ricordo. L’idea staliniana è che debbano essere prodotti solo film che esaltino l’identità nazionale, evitando gli “esperimenti”. Risultato, la produzione sovietica crolla dai 104 film del 1928 ai 18 del 1947. Assediato da impedimenti burocratici e creativi sempre maggiori, Sergej M. Ėjzenštejn muore di crisi cardiaca nel 1948.
Nonostante la fondazione di Cinecittà nel 1937, dal punto di vista quantitativo la produzione di film dell’Italia fascista non decolla fino al 1940, quando lo Stato assume il controllo dell’intera filiera cinematografica.
Il percorso del cinema del Ventennio sembra presentare delle assonanze con quello sovietico. E non soltanto perché Mussolini e Lenin condividono la definizione di cinema come “l’arma più forte” e alcune scelte stilistiche e di montaggio di nostri registi sembrano mutuate da Mosca. Ma anche perché, dallo slancio delle origini, negli anni ’30 anche la nostra produzione sembra voler recedere da posizioni rivoluzionarie. Come rileva Stefano Giani nel suo libro Dittatori al cinema (Gremese), è emblematico il destino di Vecchia guardia di Alessandro Blasetti, film del 1934 ambientato nel periodo infuocato degli scontri tra camicie nere e scioperanti comunisti che precede la Marcia su Roma. L’opera sembra avere la simpatia del Duce ma incontra l’irremovibile freddezza delle gerarchie del regime, decise ad archiviare l’immagine eversiva e squadristica del fascismo.
Al cinema di propaganda (film simbolo dell’epoca è Scipione l’Africano di Carmine Gallone) si affiancano pellicole e generi di puro intrattenimento, con i primi passi sul grande schermo di Totò, di Vittorio De Sica, dei fratelli De Filippo e altri grandi. Oppure con il genere dei Telefoni bianchi, commedie di ambientazione altoborghese basate soprattutto su intrecci sentimentali e che raccontano un’inesistente Italia priva di preoccupazioni.
Dopo la caduta del fascismo, la Repubblica Sociale Italiana sposta la sua capitale cinematografica a Venezia. La prima opera del “cinema di Salò” è Fatto di cronaca di Piero Ballerini (1944), ultimo ruolo per Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, coppia di divi-simbolo del regime, prima della loro tragica fine. Neppure la finzione della celluloide riesce a dissimulare il clima cupo dei 600 giorni. Forse una dozzina di titoli in tutto, opere drammatiche, testi teatrali o film che sarebbe inesatto definire “di guerra”, come Marinai senza stellette o Aeroporto, dedicati all’eroismo disperato di soldati ormai privi di tutto il necessario per combattere. La produzione cinematografica della RSI si interrompe il 20 aprile 1945.
Il cammino comune tra dittatura e Settima Arte, in Italia, è finito.