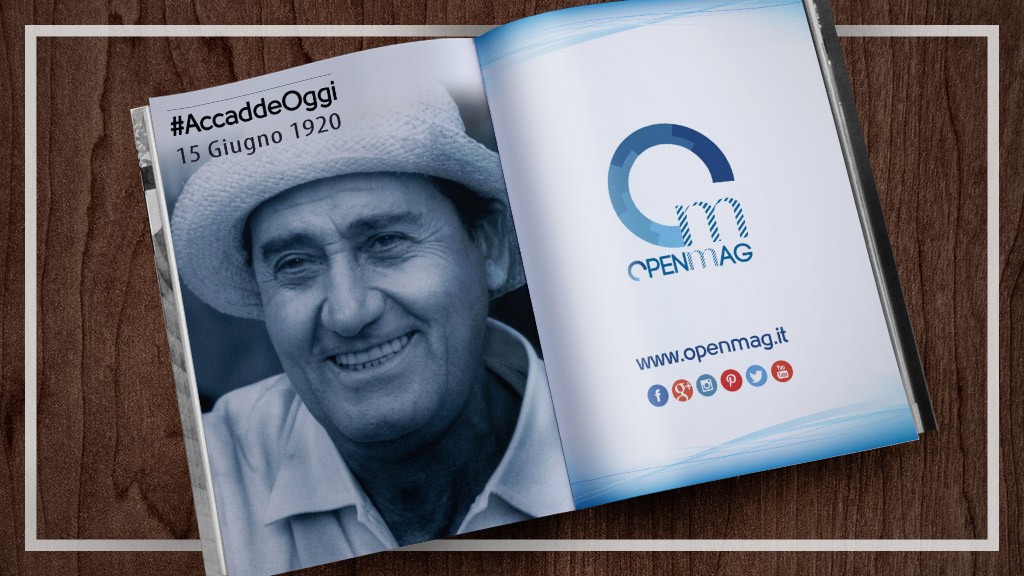Il 15 giugno 1920 nasce Alberto Sordi, l’attore che fa irrompere la modernità nel nostro cinema
Il debutto teatrale di Alberto Sordi è rovinoso. Nel 1936, insieme all’amico Gaspare Cavicchi, uno che si picca di essere esperto di palcoscenico, riesce ad essere scritturato a Milano presso il Teatro Pace. La totale incapacità dei due si traduce in una completa catastrofe. Precedentemente però, Alberto è riuscito ad avere un contratto con la Fonit per incidere dischi di favole per bambini. Lezioni su lezioni, vane, presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano per eliminare il pesantissimo accento. Eppure, nel 1937, con la sua voce cavernosa ancora zavorrata dal romanesco, vince il concorso indetto dalla Metro Goldwin Mayer per trovare il doppiatore di Ollio.
Tutto questo ci fa capire subito quale sia stata la chiave del successo di Alberto Sordi, e perché la sua popolarità trascenda i confini dello spettacolo e lo abbia trasformato in un’icona del ‘900 italiano: la sua impareggiabile modernità. E’ questo che, nella gara di popolarità con gli altri eccelsi attori suoi contemporanei, forse per un’incollatura, lo fa arrivare primo. Trovate chiuse le porte del teatro e dei piani alti dell’arte drammatica, la gavetta artistica di Alberto Sordi è fatta di radio, di cabaret e, da subito, di cinema. Questa dimestichezza maturata, fin dall’adolescenza, con le arti “nuove” e, se vogliamo, con le nuove tecniche che le supportano, gli fornisce una marcia in più per rappresentare l’Italia contemporanea.
Nel 1953, con “Un giorno in pretura”, inventa il personaggio di Nando Mericoni “l’Americano”, che avrà un successo fragoroso l’anno successivo come protagonista unico di “Un americano a Roma”. La capacità di Sordi e del regista Steno di rappresentare un’Italia del dopoguerra abbagliata dal Mito dell’America non necessita di molti commenti. Battendo tutti sul tempo, Albertone immortala una nuova generazione che vuole chiudere con le scomodità del dopoguerra, stregata da Hollywood e da Broadway, dal swing, che veste e si pettina come James Dean, che mangerebbe qualsiasi porcheria che abbia una provenienza esotica e che, pochi mesi dopo l’arrivo della tv in Italia, è già videodipendente.

Adolescente, Alberto frequenta l’Istituto di Avviamento Commerciale “Giulio Romano” di Porta Portese, ma si allontana dagli studi per inseguire il sogno di recitare (si diplomerà più avanti, come privatista). Lavora nel teatro di rivista e interpreta piccoli ruoli cinematografici. Nel 1940 è nel corpo di spedizione in Francia, 81° Fanteria. Suona i piatti nella banda musicale. A Mentone, l’impetuosa avanzata del Regio Esercito si è già ingolfata. L’ispezione di un generale li sorprende mentre, senza urgenti impegni bellici, fanno il bagno in mare.
La porta del successo è la radio. Nel 1947 esordisce in “Rosso e nero” e “Oplà”, condotte da Corrado (che usa ancora anche il suo cognome, Mantoni). L’anno successivo ha una trasmissione tutta sua, “Vi parla Alberto Sordi”, dove nascono personaggi leggendari come “Mario Pio” o “il compagnuccio della parrocchietta”.
La consacrazione sul grande schermo arriva nel 1951. Federico Fellini gli affida il suo primo ruolo importante ne “Lo sceicco bianco”. Sordi interpreta un cialtronesco divo dei fotoromanzi, per i quali, all’epoca, milioni di lettrici ogni settimana assediano le edicole. Il 1953 è l’anno della svolta: è ancora Fellini a lanciarlo nel firmamento del cinema d’autore con il memorabile ruolo ne “I vitelloni” (tutti ricordiamo immediatamente la scena di Albertone che fa il gesto dell’ombrello a degli operai da un’auto in corsa e improvvisamente la macchina si ferma); con “Un giorno in pretura” diventa star anche al botteghino. In tutto, nel ’53 interpreta 4 film. Nel ’54 saranno tredici, nel ’55, otto.
Iniziano le collaborazioni con i maggiori registi italiani. Nel 1959 gira dieci film. “La Grande guerra” di Mario Monicelli è accom
La figura del soldato eroe suo malgrado getta le basi del Sordi impegnato; i suoi ruoli ripercorrono le tappe del dopoguerra: l’ex-partigiano alle prese con il reinserimento in “Una vita difficile” (1961); l’ufficiale sbandato dopo l’8 settembre di “Tutti a casa” (1960); l’aspirante borghese della ricostruzione de “Il maestro di Vigevano” e “Il Boom” (1963).
L’altro film fondamentale del ’59 è “Il vedovo” di Dino Risi, in cui, affiancato da una strepitosa Franca Valeri, interpreta un’industriale di mezza tacca che cerca di eliminare la ricchissima moglie. Si accentua la sua propensione verso personaggi in chiaroscuro, poco o molto poco raccomandabili, a volte turpi, come il trafficante di bambini de “Il Giudizio universale” di Vittorio De Sica (1961) o il direttore di un ospizio-lager che cerca di far sbranare un’anziana e facoltosa ospite da due cani feroci in “Piccola posta” di Steno (1955), o l’infido barbablù di “Arrivano i dollari” di Mario Costa (1957). “Mafioso” di Alberto Lattuada (1961), mostra per la prima volta al grande pubblico, tramite una caustica sceneggiatura di Age e Scarpelli, Marco Ferreri e Rafael Azcona, la natura e i meccanismi di cosa nostra.

Con gli anni ’70 arrivano gli ultimi ruoli davvero grandi. “Detenuto in attesa di giudizio” (1971) di Nanni Loy è un dramma giudiziario-carcerario incredibilmente in anticipo sui tempi, che si avvale anche di un sorprendente Lino Banfi in versione drammatica. Il pensionato serial-killer di “Un borghese piccolo piccolo” (1977) di Mario Monicelli dà un volto definitivo all’Italia degenerata e cupa degli anni di piombo.
Gli anni ’80 e ’90 sono gli anni del disimpegno, del “Tassinaro”, di “Sono un fenomeno paranormale” e, nemmeno a dirlo, de “Il marchese Del Grillo”, con un Mario Monicelli stavolta più divertito e leggero. Ma c’è spazio anche per un’anticipazione dello scoppio di Tangentopoli con “Tutti dentro” (1984) e “Assolto per aver commesso il fatto” (1992). Fino all’ultimo, i suoi film, scattano un’istantanea esatta e nitida dei cambiamenti del costume e della società in Italia. E, come sempre, non sono quasi mai cambiamenti positivi.